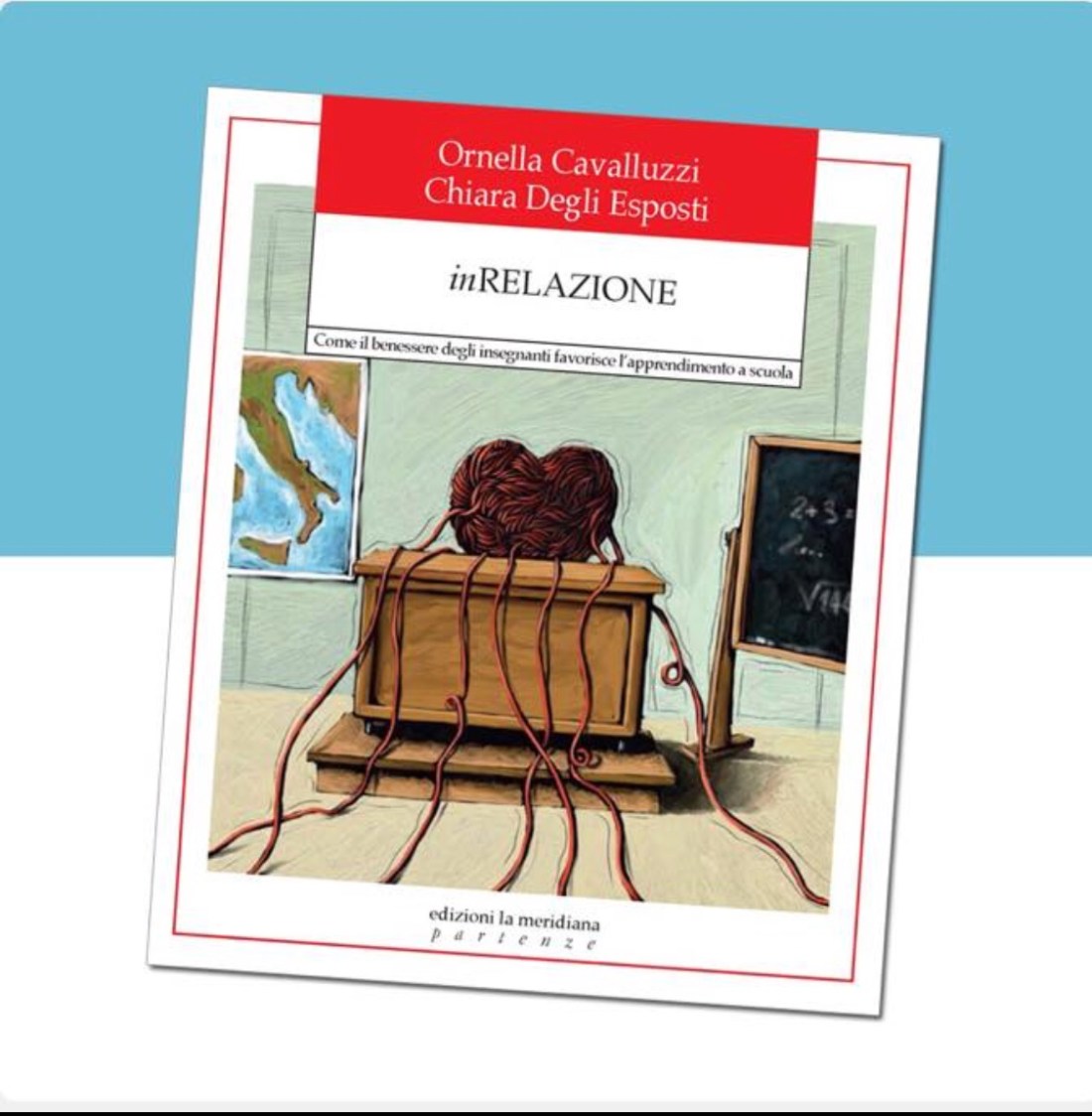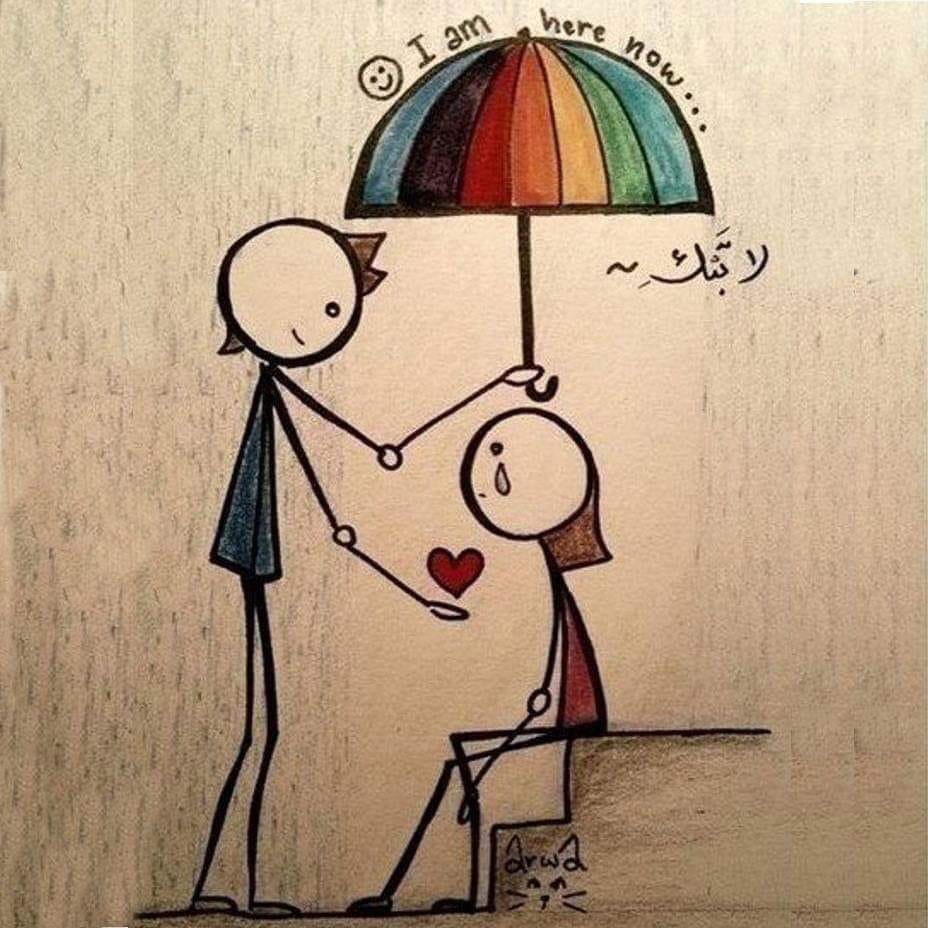Sabato 19 gennaio ho avuto il privilegio di partecipare al Convegno “La fatica dell’educare”, patrocinato dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale e organizzato dal Team inRelazione in collaborazione con la cattedra del professor Raffone dell’Universita’ La Sapienza di Roma. Il convegno, non a caso, io credo, si è tenuto in un luogo meraviglioso, dove si è respirata tanta bellezza, la Promoteca del Campidoglio.
Si è parlato di burnout e di quanto sia importante la sua prevenzione.
Sono sempre più frequenti, nella cronaca, i racconti di episodi di maltrattamento di bambini o utenti “fragili” (anziani, disabili,…) da parte di educatrici o insegnanti. Racconti che, ogni volta, mi lasciano incredula. Attonita.
E’ doloroso pensare, in queste circostanze, alla paura che hanno provato i bambini maltrattati. È doloroso sentirsi parte di un “brutto mondo” perché si fa lo stesso mestiere. È doloroso percepire i pregiudizi delle famiglie e il loro peso.
Io sono una pedagogista. Prima ancora un’educatrice. Lavoro in un nido. E sono molto fiera del mestiere che faccio; lo amo molto e mi dà tante soddisfazioni.
Ho studiato per diventare ciò che sono. Ho fatto un lungo percorso, millemila ore di tirocinio con insegnanti che, in università, mi avrebbero fermata se si fossero resi conto che non ero motivata a sufficienza. Perché educare è fatica e senza una motivazione profonda non si può fare questo mestiere.
E come me, tante…tantissime colleghe, che rispettano i bambini, li ascoltano, partecipano con entusiasmo alle loro giornate.
Fa male sentire racconti di botte, grida, vessazioni.

Tante persone…anche colleghe…sostengono che la soluzione a queste brutture siano le telecamere. Credetemi, non è così. Le telecamere possono essere un ottimo strumento di propaganda politica (e, infatti, persone che di pedagogia non ne sanno nulla stanno discutendo in Parlamento di un disegno di legge che vuole renderle obbligatorie nei nostri servizi per l’infanzia) ma non servono a prevenire i casi di maltrattamento. Potranno, forse, tamponare una situazione di emergenza ma non sono una soluzione definitiva.
Non credo che ci siano “cattive educatrici”. Ci sono, però, educatrici che, a un certo momento, iniziano a stare male. Non riescono più a emozionarsi. Si sentono inutili e inadeguate. Non trovano più soddisfazioni personali nella professione. Sono vittime del Burnout, uno stato di esaurimento fisico, emotivo e mentale che deriva dal coinvolgimento prolungato nel tempo in situazioni lavorative emotivamente impegnative, proprio come quella che si verifica in un servizio educativo in cui ci si prende cura dei bambini.
Non sto sostenendo che tutte le educatrici, prima o poi, nella loro vita lavorativa, saranno assalite dal burnout…anzi…molte non ne saranno neppure sfiorate. Non dobbiamo però pensare che a noi non accadrà mai. È in agguato. È importante, quindi, focalizzarci sulle strategie di prevenzione.
Il burnout è una forma molto seria di stress cronico, in grado di compromettere la capacità lavorativa di una persona. Chi lavora nei servizi per l’infanzia è a rischio. Diciamolo. Diciamocelo. Riflettiamoci su. Con molta attenzione e coscienza. E, soprattutto, senza paura.
Nei servizi che si occupano di infanzia sono tanti gli zoccoli duri: c’è il problema di un eccessivo numero di bambini per educatrice/insegnante (1/28 è un numero molto alto, ma è quello consentito dalla legge nella scuola dell’infanzia); c’è il problema della precarietà, delle difficoltà relazionali tra colleghe, dello scarso riconoscimento all’esterno, dei rapporti con le famiglie che, sempre più spesso, sono difficili e problematici.
Ogni educatrice, inoltre, quando inizia il suo lavoro ha delle aspettative sull’importanza dei propri compiti e sul ruolo sociale che ha, aspettative che possono essere anche molto elevate. È possibile, però, che nella realtà si scontri con il mancato riconoscimento della propria professionalità da parte dei genitori, con l’idea di una paga (giustamente o ingiustamente) percepita come inadeguata per il delicato lavoro che si svolge, col trovarsi a dover sacrificare alcuni aspetti importanti della propria vita per il lavoro. E se non si hanno le risorse (interne ed esterne) per far fronte in maniera razionale a questo iato tra aspettative e realtà, si può facilmente andare incontro al burnout.
Si legge ad un certo punto, nel libro “inRelazione”: Gli antichi greci articolavano la conoscenza in “episteme”, “techne” e “phronesis”, vale a dire “conoscenze certe”, “abilità tecniche” e “saggezza pratica”. Sono sempre state enfatizzate l’episteme e la techne, mentre è stata messa a margine la phronesis, le abilità emotive che, se ben sviluppate, hanno la capacità di moderare e di limitare l’effetto dello stesso tipico del nostro ambiente lavorativo.
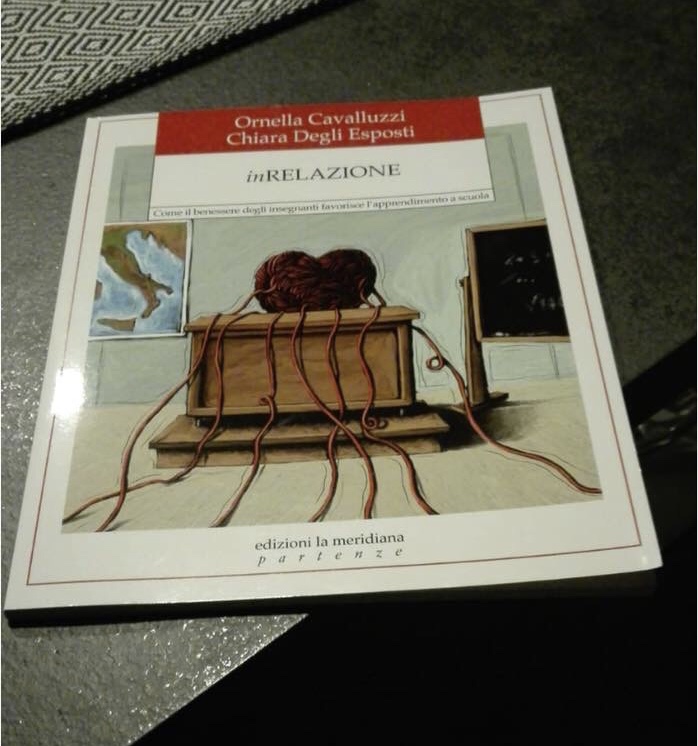
Il metodo inRelazione è un percorso di formazione che ha proprio l’obiettivo di incrementare le competenze emotive e relazionali di chi fa un lavoro di natura educativa. E’ un percorso impegnativo; copre l’arco di un interno fine settimana e tutte sappiamo quanto abbiamo bisogno del sabato e della domenica per ricaricarci e riprenderci dalle fatiche della settimana. E’, però, anche un percorso che ti aiuta a prendere coscienza di te, della tua fragilità, delle tue fatiche di professionista che lavora con i bambini. Contribuisce a renderti più solida dal punto di vista emotivo e relazionale, aiutandoti a rinforzare il Sè e dandoti strumenti e occasioni per entrare in contatto con il tuo “bambino interiore”, per ritrovare la giusta motivazione e migliorare la qualità del lavoro con i bambini.
Quando ho partecipato al training, nel settembre 2018, ero molto affaticata nonostante l’anno educativo fosse appena agli inizi. Ero alle prese con un ambientamento che sentivo impegnativo e non ero certa di avere le risorse per portarlo a termine come avrei voluto.
La formazione mi aiutato a “centrarmi” nuovamente. Ed ho cambiato sguardo su ciò che mi stata accadendo nel lavoro.
Ho capito che, per poter procedere, dovevo ascoltare le emozioni che quella situazione lavorativa aveva fatto nascere in me. Frustrazione, senso di ansia, affanno. Ho capito che dovevo mettere in campo le mie emozioni nella relazione con quella bambina che stava affrontando l’ambientamento. Non dovevo metterle da parte queste emozioni.
Solo così, infatti, questa relazione sarebbe diventata autentica e di qualità. Ho capito che potevo portare la mia fatica, la frustrazione, la difficoltà a tollerare il pianto disperato.
Si pensa che quando si sente la fatica nella relazione, sia colpa dell’altro, che è strano, sbagliato. Ma siamo sicuri che sia così? Nel nostro lavoro ci misuriamo con le difficoltà, le fatiche, perché anche noi educatrici siamo persone con dei limiti e dei difetti e con aspetti problematici nel nostro Sè. Non è facile arrivare ad essere consapevoli di questo, ma, quando accade, assumiamo una postura che ci porta ad accogliere il nostro vissuto e a scegliere, in base ad esso, come rispondere nel modo migliore alla situazione che stiamo vivendo, con il rispetto dei vissuti e dei bisogni della persona con cui siamo entrate in relazione.
Ci vuole tanta concentrazione per riuscire ad assumere una postura di questo genere…così è stato per me…Forse mi ha aiutata l’esperienza che ho maturato in tanti anni di lavoro con i bambini, le formazioni passate, il bisogno di sentirmi bene nel mio contesto lavorativo…
Quando ho ripreso il lavoro dopo il fine settimana di formazione ho sentito che ero pronta per guardare a quell’ambientamento con occhi differenti. Mi ha aiutata il sintonizzarmi con lo stato emotivo della bambina in ambientamento…con la sofferenza per l’allontanamento della madre, con la fatica a stare in un luogo nuovo e poco conosciuto, con persone anch’esse nuove e poco conosciute…L’ho abbracciata tanto, le ho raccontato del gruppo di bambini di cui avrebbe fatto parte, le ho fatto vedere le fotografie dell’anno precedente…Ad un certo punto non era più importante, per me, che smettesse di piangere. Era importante che sentisse che accoglievo il suo pianto e che lo avrei accolto finchè ne avesse avuto il bisogno. Questo mi ha fatto sentire meglio…
Se ti focalizzi sul voler far cessare un pianto disperato di un bambino che sta male, può nascere dentro di te un grande senso di frustrazione e un elevato livello di stress; se, al contrario, lasci che il bambino si esprima con la modalità di cui sente la necessità, che può essere anche il pianto, piano piano ti accorgerai che lui si sente meglio e, con lui, accadrà anche a te di sentirti meglio.
Ci si deve, quindi, focalizzare sulla qualità della relazione: in questo modo si può prevenire il burnout. Perché le relazioni siano di qualità in un contesto educativo è importante mettere in campo una buona capacità di ascolto, esterno ma anche interno: bisogna saper mettersi in contatto con l’altro e, contemporaneamente con sé stessi; perché questo succeda bisogna avere una buona consapevolezza di sé.
Questo ho appreso nel corso del training inRelazione. E credo che sia molto importante per essere una professionista migliore.